La “rivoluzione digitale” investe il mondo dei beni culturali per valorizzare il patrimonio storico-sociale del territorio lombardo e renderlo immediatamente accessibile alla comunità scientifica e al grande pubblico. E’ questo il senso del progetto Lombardia Digital Archives, voluto da Regione Lombardia ed attuato a valere sul POR OB. 2 FSE 2007/2013 – asse IV “Capitale umano”.
Si conclude con il mese di dicembre 2015 un lungo lavoro di riorganizzazione, catalogazione e digitalizzazione che ha interessato alcune delle collezioni documentali conservate presso l’Archivio di Etnografia e Storia Sociale (AESS) di Regione Lombardia.
A partire dal gennaio 2016, 40 anni di storia e costume delle comunità lombarde saranno fruibili online attraverso il rinnovato sito raggiungibile all’indirizzo: http://www.aess.regionelombardia.it a cui gli utenti potranno accedere per consultare liberamente il database che raccoglie materiali realizzati o acquisiti dalla Regione Lombardia dal 1970 ad oggi: un patrimonio di cultura legato alle comunità e ai luoghi, alle attività tradizionali del mondo del lavoro, agli usi, alle consuetudini sociali e alle diffuse competenze artistiche e artigianali.
La Lombardia è storicamente una fucina di creatività e lavoro, una grande impresa culturale e creativa. Con questo progetto si è inteso riorganizzare e rendere immediatamente disponibili collezioni documentarie che nascono dalla creatività dei grandi protagonisti della vita artistica della regione, ma anche da quella dei cittadini lombardi, uomini e donne che hanno modellato attraverso il lavoro il proprio territorio e che ogni giorno creano le condizioni sociali e culturali della loro vita comune.
Il progetto ha interessato circa 35mila supporti fotografici (stampe, negativi, positivi di vario formato), più di 2mila ore di documenti audio e video (filmati 16 e 8 mm, VHS, nastri magnetici ¼ e ½ pollice, DAT, MiniDV, ecc.), 10mila pagine di pubblicazioni monografiche, vari manifesti e cartelloni.
Con questo intervento è stata incrementata la consistenza dell’archivio digitale che racconta vita e costumi delle comunità della Regione attraverso alcuni temi chiave: il lavoro, le grandi opere pubbliche, i paesaggi montani, il mondo giovanile, il tempo libero, la ritualità, i saperi artigianali, le tecniche di coltivazione, i grandi eventi politici e sindacali, i racconti della tradizione orale e lo spettacolo di piazza.
Tra i documenti più significativi oggetto della riproduzione digitale, scatti di grandi maestri della fotografia come Ferdinando Scianna, Armando Rotoletti, Arno Hammacher, Toni Nicolini, nonché di collaboratori storici quali Pierluigi Navoni, Riccardo Schwamenthal ed Ernesto Fazioli.
La finalità primaria che ha mosso questo progetto è stata quella di preservare dal lento deterioramento documenti affidati a supporti analogici facilmente deperibili, perché senza un’adeguata conservazione delle fonti documentali la sopravvivenza della memoria individuale e collettiva non può essere garantita.
Secondo, ma non meno importante obiettivo, è stato quello di amplificare il messaggio culturale dell’AESS, trasformandolo in un “dizionario universale” immediatamente accessibile a tutti, uno strumento utile alla ricerca, alla scuola e al servizio educativo, ma che si presta anche all’uso individuale di quanti siano semplicemente interessati a conoscere o a ricordare.
Il lavoro, che è stato affidato, tramite gara ad evidenza pubblica, alle società Opendoc di Milano e AM Image di Bologna in RTI, si è articolato in 5 fasi: inventario e selezione delle risorse, catalogazione, digitalizzazione, conservazione e valorizzazione con pubblicazione in rete.
Dal punto di vista tecnico questo progetto, che ha impegnato per 10 mesi un gruppo composto da più di 20 persone tra tecnici di digitalizzazione ed esperti archivisti, ha presentato diverse criticità quali la necessità di trattare supporti desueti per i quali è stato necessario impiegare strumenti di lettura non più in commercio; lo stato di conservazione del materiale che in alcuni casi ha richiesto interventi di restauro finalizzati al rendere trattabili i materiali; la presenza di materiale mai inventariato per il quale è stato necessario effettuare ricerche mirate.
I RACCONTI DELL’AESS
Per promuovere la conoscenza delle attività di ricerca dell’Archivio di Etnografia e Storia Sociale è stato realizzato un percorso di rilettura dei materiali documentari attraverso una serie di racconti, pensati e presentati per comunicare con un pubblico variegato, non necessariamente di addetti ai lavori. Per ognuna delle dodici province lombarde si è scelto di selezionare un tema legato ad un’attività di rilievo dell’Archivio e, a partire dal tema, identificare eventi e personaggi intorno ai quali costruire le storie.
I racconti hanno come protagonisti attori che agiscono su un palcoscenico che si estende, idealmente, in tutto il territorio della Regione. Le storie che interpretano si svolgono in un arco temporale lungo secoli. Per questo, per amalgamare e valorizzare una materia densa e complessa qual è l’etnografia, lo scrittore Roberto Moroni, propone un classico espediente letterario: lo “Spirito del tempo” è la voce narrante, entità sovra-dimensionale libera di incarnarsi di volta in volta nei personaggi al centro di queste storie. Il canto delle mondine, l’eccellenza nella tecnica della panificazione, l’arte antica e moderna dei burattinai sono solo alcuni dei temi che vengono plasmati mediante il ricorso a registri e accenti narrativi differenti quali la commedia, il dramma, il noir.
L’Archivio di Etnografia e Storia Sociale di Regione Lombardia è un istituto pubblico che studia e valorizza il patrimonio di cultura tradizionale delle comunità lombarde, con particolare attenzione al patrimonio culturale immateriale, riconosciuto dalla Convenzione internazionale dell’Unesco e dalla legge regionale n. 27/2008.
Questo patrimonio include espressioni viventi e tradizioni che sono state trasmesse di generazione in generazione, arti, saperi, pratiche e conoscenze che danno alla comunità un senso di identità e di appartenenza, espressioni della diversità culturale tra i popoli e testimonianza della creatività umana.
Promosso da Roberto Leydi agli inizi degli anni Settanta, l’Archivio costituisce un’esperienza innovativa all’interno della nascente istituzione regionale e testimonia una parte importante della storia della nostra regione. Attraverso le indagini etnografiche condotte direttamente sul territorio, l’acquisizione di fondi documentari sonori, fotografici e audiovisivi, la promozione di progetti di ricerca e di divulgazione, conserva una preziosa documentazione che è testimonianza di una esperienza unica nel contesto delle istituzioni culturali nazionali.
Le prime ricerche “sul campo”, a partire dal 1972, seguono lo schema della suddivisione territoriale e amministrativa della nostra regione. Per quanto sia oggi naturale accostare e confrontare tematiche e filoni di indagine, riconoscibili e appartenenti a determinati contesti, così non sarebbe possibile se non vi fosse stata quella iniziale e rigorosa intuizione. Una scelta dunque, non casuale, che anticipa programmi di politica culturale volti a indagare distretti culturalmente omogenei, paesaggi culturali dai tratti distintivi e peculiari, pratiche espressive e rituali, saperi e tecniche profondamente radicate nelle aree più conservative della nostra regione. Quell’intuizione porta a un’intensa produzione editoriale che rappresenta un caso eccezionale nel panorama italiano degli studi antropologici e soprattutto in relazione ad altri archivi e istituzioni pubbliche.
Basti pensare alla collana Mondo Popolare in Lombardia, con la pubblicazione di quindici volumi suddivisi per realtà provinciali, che attesta l’intenso lavoro di ricerca scientifica, alla collana discografica Documenti della Cultura Popolare, con undici dischi dedicati agli aspetti musicali della Lombardia, alla collana video-cinematografica Tracciati. Memorie per un Archivio. Culture Lombarde, con ventotto film-documentari che documenta dalla cultura rituale a quella del lavoro, dal mondo della piazza al teatro popolare.
· Il patrimonio fotografico dell’Archivio è costituito da oltre 1.000.000 di immagini e circa 30.000 file digitali di immagini storiche e contemporanee
· La nastroteca è costituita da oltre 6.000 supporti audio (nastri magnetici di vario formato, audiocassette, dischi vinile, CD, DAT) e da circa 1.000 file digitali di registrazioni audio originali
· La videoteca è costituita da oltre 4.500 supporti video di vario formato (pellicole, 16mm., 8 e super8, betacam, VHS, MiniDV, DVD) e da circa 945 file digitali.
· La Biblioteca è significativa per l’alta specializzazione delle sue pubblicazioni, che si declinano tra monografie (circa 4.500), periodici di settore (circa un centinaio, di cui oltre 20 in abbonamento corrente) e una importante mediateca (circa 1.500 titoli).
LOMBARDIA DIGITAL ARCHIVES – I RACCONTI
Per promuovere la conoscenza del progetto Lombardia Digital Archives e delle attività di ricerca dell’Archivio di Etnografia e Storia Sociale (AESS) è stato realizzato un percorso di rilettura dei materiali documentari attraverso una serie di racconti firmati dallo scrittore Roberto Moroni, pensati e presentati per comunicare con un pubblico variegato, non necessariamente di addetti ai lavori.
Per ognuna delle dodici province lombarde si è scelto di selezionare un tema legato ad un’attività di rilievo dell’Archivio e, a partire dal tema, identificare eventi e personaggi intorno ai quali costruire le storie.
Roberto Moroni è nato a Milano nel 1968. Ha pubblicato alcuni racconti e tre romanzi (La Verità Vadovunque, Dalai Editore 2000; Perduto per sempre, Rizzoli 2006; I migliori di noi, Feltrinelli 2010). Da quindici anni vive a Roma, dove lavora come autore e produttore per radio e televisione.
Di seguito i primi quattro racconti disponibili.
IO SONO LO SPIRITO DEL TEMPO
La mia vita è una cintura.
Lo dico sempre a tutti, e quasi tutti di solito ridono, però alla fine capiscono cosa c’è dietro una frase del genere. Non lo capiscono subito, perché la mia è una battuta, quindi è detta per far ridere. Infatti alla battuta segue una risatina, poi un’altra battuta detta da qualcun altro, poi ancora una risatina, eccetera. Ma quando poi tornano a casa, e camminano, oppure quando magari due giorni dopo passano davanti al mio negozio, pensano: “Ecco, il negozio di Wen – la sua vita è una cintura”. E anche se hanno riso quando io l’ho detto, adesso ci ripensano e provano rispetto. Era lì che volevo arrivare quando la facevo, la battuta – al rispetto.
 Da quando sono arrivato a Milano, trentasette anni fa, io non ho fatto altro che cinture. La mia famiglia è di Shash, una cittadina vicino allo Yangtze. Avevo due genitori, un fratello e due sorelle quando sono partito, adesso rimane solo una sorella, e non la sento da tanto tempo perché abbiamo litigato. Sono arrivato nel momento peggiore, nel ’41. Tempo tre giorni e io e i miei cugini siamo sfollati in Brianza, perché a Milano c’erano i bombardamenti. Non ho nemmeno fatto in tempo a rendermi conto di come fosse fatta la città, mi han subito portato via e siamo stati quasi due anni in una specie di stalla. Quando siamo tornati, avevo una moglie e non sapevo dove andare. All’inizio siamo stati dai cugini nel loro appartamento di via Giusti. Eravamo un po’ uno sull’altro perché nel frattempo si erano sposati anche loro. Ma poi Chan – mia moglie – è rimasta incinta, e ci siamo resi conto che bisognava assolutamente trovare un posto per noi, anche per lavorare. Così abbiamo trovato un seminterrato in via Lomazzo. Era perfetto. Avevamo la nostra stanza col letto, una cucina e un soggiorno che poteva benissimo funzionare da laboratorio. Per il bagno si doveva attraversare il cortile, ma che problema è attraversare il cortile, dico io? In quegli anni in Brianza i cugini mi avevano insegnato il lavoro del pellame – la misura, il taglio, le fibbie, perfino elementi di concia. Ho imparato tutto, potevo fare ogni tipo di borsa, scarpe, portafogli, giacche – tutto. Ma ho sempre pensato che la missione di un uomo consistesse nel dedicarsi a una cosa sola, e farla meglio di tutti gli altri. Ed ecco la cintura. Ho lasciato che Chan facesse tutto il resto – lo faceva e lo fa bene, senza eccellere – per potermi concentrare solo sulla cintura. I risultati non sono arrivati subito, naturalmente. Quando è nato Jian abbiamo passato un momento di crisi, perché era il 1950, c’era il boom, un mucchio di ordinazioni e noi non riuscivamo a stargli dietro. Abbiamo preso due ragazze a fare il lavoro di mia moglie, che doveva star spesso dietro a Jian, malato di febbre reumatica. Ma le ragazze non erano brave e veloci come Chan. Così abbiamo iniziato a perdere ordini, e dopo un po’ non sono più stato in grado di pagare le ragazze. Ho dovuto mandarle via. Ed eravamo anche preoccupati per il bambino. Preoccupati per il bambino, preoccupati per i soldi – quando stai così, riuscire a lavorare è difficilissimo. Mi è venuto l’esaurimento. Ogni giorno mi alzavo, e vedevo la barca colare a picco. Avremo passato così almeno tre anni – un incubo. Poi è arrivata una fortuna, o meglio, è arrivato il commendator Tazio Gismondi, un imprenditore ramo alimentare, che tutti i lunedì e venerdì si prendeva due ore per accompagnare il figlio asino a lezione di latino da una professoressa che abitava nel mio condominio. Ci siamo conosciuti così. Era molto grasso, aveva l’affanno, fumava da matti. La prima volta che ci siam visti è venuto da me a chiedermi dov’era la professoressa, poi, dopo averci lasciato il figlio è venuto a visitare il laboratorio, perché pioveva forte e non c’erano posti dove ripararsi. Le mie cinture l’hanno impressionato. E così si è creata un’abitudine, ha preso a venir sempre. Si sedeva su una sedia e ci mettevamo a chiacchierare finché il figlio non finiva la lezione. E’ stato lui che mi ha fatto cominciare a fumare. Ogni tanto mi chiamava “Cinturìn”, così, simpaticamente. Finché un giorno mi ha detto “Uéla Wen, le tue cinture sono la fine del mondo, ma finché stan qua sotto nessuno le vede, poi per forza te le pagano poco. Senti, ma perché non ti apri un negozio sulla Paolo Sarpi? Lo chiamiamo Chin-Tu-Rin, ci mando i miei amici, sai gli affari? Uno ha bisogno di una cintura, io gli dico Vai, vai dal Cinturìn. Tutta la gente che conosco che ha bisogno di cinture, ce l’hai un’idea?”. Io gli ho detto “Eh, commendatore, ma io non ci ho mica i dané per farla una roba del genere”, e lui subito, “E ma mica ce li devi mettere tu, i dané, c’è qui la Gismondi International che finanzia il progetto!”. Così nel ’61 abbiamo aperto, proprio sulla Paolo Sarpi. I l Jian, che poi si è ripreso dai reumi, s’è messo al negozio con la madre, io ho ri-assunto le ragazze e gli ho insegnato a specializzarsi sulle cinture, così che alla fine facciamo tutto, dal produttore al consumatore – ma solo cinture. E infatti dal ’61 se tu ti vuoi comprare una cintura, hai un solo posto dove andare, il Chin-Tu-Rin di Paolo Sarpi, perché il Chin-Tu-Rin fa solo cinture, ma di tutti i tipi e per tutte le tasche.
Da quando sono arrivato a Milano, trentasette anni fa, io non ho fatto altro che cinture. La mia famiglia è di Shash, una cittadina vicino allo Yangtze. Avevo due genitori, un fratello e due sorelle quando sono partito, adesso rimane solo una sorella, e non la sento da tanto tempo perché abbiamo litigato. Sono arrivato nel momento peggiore, nel ’41. Tempo tre giorni e io e i miei cugini siamo sfollati in Brianza, perché a Milano c’erano i bombardamenti. Non ho nemmeno fatto in tempo a rendermi conto di come fosse fatta la città, mi han subito portato via e siamo stati quasi due anni in una specie di stalla. Quando siamo tornati, avevo una moglie e non sapevo dove andare. All’inizio siamo stati dai cugini nel loro appartamento di via Giusti. Eravamo un po’ uno sull’altro perché nel frattempo si erano sposati anche loro. Ma poi Chan – mia moglie – è rimasta incinta, e ci siamo resi conto che bisognava assolutamente trovare un posto per noi, anche per lavorare. Così abbiamo trovato un seminterrato in via Lomazzo. Era perfetto. Avevamo la nostra stanza col letto, una cucina e un soggiorno che poteva benissimo funzionare da laboratorio. Per il bagno si doveva attraversare il cortile, ma che problema è attraversare il cortile, dico io? In quegli anni in Brianza i cugini mi avevano insegnato il lavoro del pellame – la misura, il taglio, le fibbie, perfino elementi di concia. Ho imparato tutto, potevo fare ogni tipo di borsa, scarpe, portafogli, giacche – tutto. Ma ho sempre pensato che la missione di un uomo consistesse nel dedicarsi a una cosa sola, e farla meglio di tutti gli altri. Ed ecco la cintura. Ho lasciato che Chan facesse tutto il resto – lo faceva e lo fa bene, senza eccellere – per potermi concentrare solo sulla cintura. I risultati non sono arrivati subito, naturalmente. Quando è nato Jian abbiamo passato un momento di crisi, perché era il 1950, c’era il boom, un mucchio di ordinazioni e noi non riuscivamo a stargli dietro. Abbiamo preso due ragazze a fare il lavoro di mia moglie, che doveva star spesso dietro a Jian, malato di febbre reumatica. Ma le ragazze non erano brave e veloci come Chan. Così abbiamo iniziato a perdere ordini, e dopo un po’ non sono più stato in grado di pagare le ragazze. Ho dovuto mandarle via. Ed eravamo anche preoccupati per il bambino. Preoccupati per il bambino, preoccupati per i soldi – quando stai così, riuscire a lavorare è difficilissimo. Mi è venuto l’esaurimento. Ogni giorno mi alzavo, e vedevo la barca colare a picco. Avremo passato così almeno tre anni – un incubo. Poi è arrivata una fortuna, o meglio, è arrivato il commendator Tazio Gismondi, un imprenditore ramo alimentare, che tutti i lunedì e venerdì si prendeva due ore per accompagnare il figlio asino a lezione di latino da una professoressa che abitava nel mio condominio. Ci siamo conosciuti così. Era molto grasso, aveva l’affanno, fumava da matti. La prima volta che ci siam visti è venuto da me a chiedermi dov’era la professoressa, poi, dopo averci lasciato il figlio è venuto a visitare il laboratorio, perché pioveva forte e non c’erano posti dove ripararsi. Le mie cinture l’hanno impressionato. E così si è creata un’abitudine, ha preso a venir sempre. Si sedeva su una sedia e ci mettevamo a chiacchierare finché il figlio non finiva la lezione. E’ stato lui che mi ha fatto cominciare a fumare. Ogni tanto mi chiamava “Cinturìn”, così, simpaticamente. Finché un giorno mi ha detto “Uéla Wen, le tue cinture sono la fine del mondo, ma finché stan qua sotto nessuno le vede, poi per forza te le pagano poco. Senti, ma perché non ti apri un negozio sulla Paolo Sarpi? Lo chiamiamo Chin-Tu-Rin, ci mando i miei amici, sai gli affari? Uno ha bisogno di una cintura, io gli dico Vai, vai dal Cinturìn. Tutta la gente che conosco che ha bisogno di cinture, ce l’hai un’idea?”. Io gli ho detto “Eh, commendatore, ma io non ci ho mica i dané per farla una roba del genere”, e lui subito, “E ma mica ce li devi mettere tu, i dané, c’è qui la Gismondi International che finanzia il progetto!”. Così nel ’61 abbiamo aperto, proprio sulla Paolo Sarpi. I l Jian, che poi si è ripreso dai reumi, s’è messo al negozio con la madre, io ho ri-assunto le ragazze e gli ho insegnato a specializzarsi sulle cinture, così che alla fine facciamo tutto, dal produttore al consumatore – ma solo cinture. E infatti dal ’61 se tu ti vuoi comprare una cintura, hai un solo posto dove andare, il Chin-Tu-Rin di Paolo Sarpi, perché il Chin-Tu-Rin fa solo cinture, ma di tutti i tipi e per tutte le tasche.
 Un po’ prima dell’apertura del negozio, verso il Natale del ’60, visto che le cose si mettevano bene, con mia moglie abbiamo deciso di fare un altro figlio. Così è nata Jie, che ci è sembrata subito bellissima.
Un po’ prima dell’apertura del negozio, verso il Natale del ’60, visto che le cose si mettevano bene, con mia moglie abbiamo deciso di fare un altro figlio. Così è nata Jie, che ci è sembrata subito bellissima.
Per dieci, dodici anni è stata la vita che ho sempre desiderato. La vita che chiunque desidererebbe.
Jie cresceva bene, a scuola era la prima della classe. “Sua figlia ha un’intelligenza superiore”, mi diceva la maestra. Ero così fiero.
Jian era bravissimo, un venditore nato. Insieme a Chan mandava avanti il negozio una meraviglia. Il commendator Gismondi aveva smesso di passare, suo figlio aveva finito il liceo e non aveva più avuto bisogno di lezioni di latino. In compenso ci mandava sempre clienti, come aveva detto, e i clineti ci portavano sempre i suoi saluti. Aveva mantenuto la promessa: a Milano, chiunque voleva comprare una cintura veniva da noi, come chiunque voleva comprare il panettone andava dal Motta, o dall’Alemagna. Io stavo in laboratorio fino alle sette, poi si cenava, poi ogni tanto facevo un mah-jong con gli altri commercianti nel retro del ristorante di Wu. Non mi è mai piaciuto giocarci, a mah-jong, ma è importante mantenere i rapporti con gli altri commercianti della comunità, specialmente quando la tua attività ha molto successo e possono nascere delle invidie.
E’ stato tutto stupendo, fino al 1976.
Poi Jie ha iniziato a frequentare gente sbagliata. Prima cinesi, poi italiani. “Proletari”, diceva lei. “Sbandati”, pensavo io.
“Non mi va che stai in giro con quelle persone”, le dicevo. Lei non mi ascoltava.
“Fai qualcosa”, mi diceva Chan, “Seguila, vedi dove va”. Ma io avevo un sacco di lavoro, forse anche paura. Non riuscivo a parlarci, con Jie, perché se ci parlavo lei mi rispondeva in un modo per cui avrei dovuto picchiarla, e non ho mai picchiato i miei figli. Ho sottovalutato il problema, oppure l’ho capito e sono fuggito. Finché una volta, al ristorante di Wu, mi hanno preso da parte e mi hanno detto Jie che si bucava, che l’avevano vista, seduta sul marciapiede con una siringa nel braccio e gli occhi al cielo. Ma ormai era troppo tardi. L’hanno ritrovata al Monte Stella, con la bocca aperta, una mattina di febbraio.
Siamo andati avanti, ma io non ero più quello di prima. Lavoravo giorno e notte, per cercare di non sentire il dolore.
Dopo qualche mese, Chan si è ammalata. Alla fine dell’estate non c’era già più. Per Jian è stato un colpo tremendo, anche più della morte della sorella.
“Non riesco più a stare qui”, mi ha detto una sera, mostrandomi un biglietto per Pechino.
Ero rimasto solo.
Avevo chiuso il negozio, vivevo delle giacenze di cassa.
Non passava giorno che non pensassi di strangolarmici, con una delle mie maledette cinture. Passavo i miei pomeriggi bevendo té nel laboratorio, guardando il muro. Da un po’ non mettevo le mani sulla pelle, sui miei strumenti, che stavano lì a prender polvere.
Verso la fine di uno di questi pomeriggi è arrivato un vecchio grassissimo, barba bianca, seduto su una carrozzella spinta da un uomo in livrea, col cappello e tutto quanto. Il vecchio ha dato due scatarrate, poi:
“Ch’el scusi, eh. Ch’el sa minga dov’è l’è finito il Cinturìn?”.
Ci ho messo un po’, poi l’ho riconosciuto – era lui, il commendator Gismondi. Dieci anni almeno che non lo vedevo. Mi aveva dato un sacco di soldi per aprire il negozio, era passato qualche volta a vedere se gli affari andavano bene, poi era sparito. Avevo pensato che la vita lo avesse portato chissà dove, era un uomo che aveva affari in tutto il mondo. E in effetti, anche se lo avessi cercato, non sapevo dove avrei potuto trovarlo. Ma non lo avevo cercato, perché le cose andavano bene, e non volevo disturbarlo. Non mi sono mai dimenticato che lui era un commendatore, io un artigiano cinese.
Mi limitavo a mandargli una cartolina di Natale direttamente alla Gismondi, alla fabbrica, ogni anno, con una foto della mia famiglia, dei figli che crescevano, anche grazie a lui. Pensavo che, in un modo o nell’altro, gli sarebbe arrivata. E se non gli fosse arrivata, be’, io comunque gliel’avevo spedita.
Lui non si era più fatto vivo, non aveva mai preteso una quota degli incassi, anche se ne aveva tutto il diritto – del resto, i fondi per aprire un negozio come il mio sono una cifra enorme per me, ma quattro soldi per uno come lui.
Poi, un Natale, la cartolina e la foto con la famiglia non gliele avevo mandate, perché la famiglia non ce l’avevo più.
Erano passati un paio di mesi, ed eccolo lì.
Dovevo rispondere a quella domanda: “Ch’el sa minga dov’è l’è finito il Cinturìn?”.
“Ma sono io, il Cinturìn”, gli ho detto.
“Ue’, Wen! Fa’ minga el pirla”, ha detto. “Che lo so bene chi sei tu, mica mi sono rincoglionito fino a questo punto!”, e giù un’altra scatarrata. “Io dicevo il negozio”.
E lì, lì gli ho raccontato la storia di quegli ultimi anni. E della chiusura.
“E poi”, gli ho detto, “Io sto in laboratorio. Chi ci metto in negozio? Non c’è nessuno che possa sostituire mia moglie e mio figlio!”.
A quel punto, il commendatore ha alzato la testa e ha guardato il maggiordomo, come a dire: “Ma hai sentito cosa mi sta dicendo questo qua?”.
Poi è tornato a guardarmi.
“Uè! Te mi fai il furbetto, ma va’ che io ti prendo in castagna, né?”.
“Non capisco”, ho detto io.
“Le chiavi, dai”, ha detto lui aprendomi il palmo della mano davanti.
“Eh?”
“DAMMI LE CHIAVI DEL NEGOZIO, DIO SVIZZERO!”
“Ma…”
“Senti, Cinturìn. Io in cinquant’anni ho tirato su un impero della madonna dal niente. Dal niente! Ma lo sai come ci sono riuscito? Ci sono riuscito perché la gente faceva quello che dicevo io. Ubbidienza. Zitti. Mosca. Quindi, adesso favorisci le chiavi del negozio. Che poi sarebbe mio, sarebbe”.
La mattina dopo alle sei picchiano alla porta, io sto ancora lì in pigiama. Apro, è l’uomo con la livrea.
“Chiedo scusa, il commendatore è in negozio. Abbiamo riaperto. I libri contabili sono in cinese, non ci capisce niente – dice se va lei”.
Da quel giorno, io faccio le cinture – sì, ho ripreso.
Lui sta in negozio tutti i giorni, e le vende.
Ha anche alzato i prezzi, ma la merce va via meglio che ai tempi di Chan e Jian.
Gli amici cinesi di Paolo Sarpi il commendatore lo chiamano “Chin-Tu-Ron”, perché è sì vecchio, ma anche una belva, un cowboy – vende come un dannato.
Non so quanto durerà, questa storia. Non so fino a quando gli andrà di venir qui ogni mattina alle sei con l’uomo in livrea, aprire il negozio e vendere cinture.
Certo, ormai sono quasi quattro mesi.
Per le foto di Milano ©Armando Rotoletti/AESS-Regione Lombardia Comunità cinese a Milano, 1992
Cremona: Il canto che ti parla di me
 IO SONO LO SPIRITO DEL TEMPO
IO SONO LO SPIRITO DEL TEMPO
e mi han cantato in tanti modi, e il canto che meglio ti parla di me è quello delle tre sorelle. Le tre sorelle mi sanno spiegarti meglio perché cantano in terze – lo sai cosa vuol dire?
La prima sta al centro e racconta la storia di me, della faccia che vedi, delle parole che parlo.
La seconda sta a sinistra e novella la fatica, il costo: dice di me prostrata. Canta la canna spezzata per strappar l’erba malata dal riso, i morsi di biscia e d’insetto, le piaghe e i sonni brutti e gelati su montagnette d’aghi di paglia.
La terza sta a destra e racconta il vero di me, ed è quella che nel canto senti meno, perché il vero di me è l’amore. E di quello, che è l’unico mio, non saprai mai davvero.
Il canto mondino per terze è una grande invenzione, perché non sente padroni e scivola e devia come vuol lui. Non è temperato, non segue codice, è anarchico e fiero, è tutto quel che noi vorremmo essere e non siamo. Son tre binari paralleli che non chiudono mai, non risolvono come nella musica per signori. Perché noi non siam signori – la storia va avanti sempre e non risolveremo mai.
Le sorelle mi cantano bene, svuotandosi tutte per riempirsi di me, che son una e son tante.
 Son la biondina di Voghera – mi avete mai visto? Sono la bellezza nella nebbia, sono la stella tornata fresca dall’acquitrino, son la mondina dalle trecce d’oro che aspetta il moroso sotto al pioppo. Tutti passano, tutti dicono: guarda la biondina di Voghera che aspetta. E alla fine, dopo averne visti tanti, il moroso arriva, e mi dà la carezza che volevo. Ma passano i giorni, comincio a star male, e vado da mamma. Lei mi mette a letto, chiama il dottore. Il dottore dice che il male bisognava curarlo prima, tenendomi in casa per non lasciarmi far l’amore con i soldati. Perché i soldati son giovanotti che l’amore non lo sanno fare: loro promettono di sposarti, poi dopo ti lasciano in libertà.
Son la biondina di Voghera – mi avete mai visto? Sono la bellezza nella nebbia, sono la stella tornata fresca dall’acquitrino, son la mondina dalle trecce d’oro che aspetta il moroso sotto al pioppo. Tutti passano, tutti dicono: guarda la biondina di Voghera che aspetta. E alla fine, dopo averne visti tanti, il moroso arriva, e mi dà la carezza che volevo. Ma passano i giorni, comincio a star male, e vado da mamma. Lei mi mette a letto, chiama il dottore. Il dottore dice che il male bisognava curarlo prima, tenendomi in casa per non lasciarmi far l’amore con i soldati. Perché i soldati son giovanotti che l’amore non lo sanno fare: loro promettono di sposarti, poi dopo ti lasciano in libertà.
E son la Nina, la mora magretta dai capelli più lunghi di tutte. Son partita con la spazzola che mi ha regalato mia sorella maggiore. Per i quaranta dì di monda ce l’avrò in tasca insieme al falcetto. Non m’importa dei dolori, non m’importa dell’acqua ghiaccia e delle caviglie che scoppiano; non m’importa dei moscerini e ancora meno del sole che mi spreme la testa; non m’importa del riso e fagioli e fagioli e riso, tutte le mane e tutte le sere; non m’importa del caposquadra e del suo bastone, che alla luce mi grida dietro e al buio mi dà le caramelle per farmi sdraiare.
Ho la mia spazzola.
E quando torno, se non riconoscerai il mio viso gonfio e sfatto, riconoscerai almeno i miei capelli.
E son Armellina, la bimba carina, mandata a prendere il desinare dopo aver rastrellato l’erba murellina. L’erba murellina è un’erba molto amara, serve solo a farci faticare, e farci venir fame.
 Di tutte han scelto me, perché sono la più piccina, e la mia fatica può aspettare. Mi allontano dal campo, salgo sul crinale e inizio a camminar veloce ché le compagne van sfamate.
Di tutte han scelto me, perché sono la più piccina, e la mia fatica può aspettare. Mi allontano dal campo, salgo sul crinale e inizio a camminar veloce ché le compagne van sfamate.
Sulla strada c’è un ragazzo, forse lo conosco, forse no. Speriamo non mi fermi, devo far veloce, le compagne van sfamate.
“Dove vai bella Armellina, tutta veloce col pentolino?” – e mi prende per un braccio.
“Vado a prendere il desinare, le compagne van sfamate”.
“Vieni qui, bella Armellina, lascia stare il pentolino” – e mi prende per l’altro braccio.
“Devo correre veloce, lascia stare! Lascia stare! Devo prendere il desinare, le compagne van sfamate” – e mi ferma la prima gamba.
“Lascia stare il pentolino, vieni qui a fare l’amore” – e mi ferma la seconda gamba. E mi prende e mi butta all’ombra, nel prato.
Dalla tasca prendo il coltello.
“De-vo! Pren-de-re! Il de-si-na-re! Le! Com-pa-gne! Van! Sfa-ma-te!” – ogni suono un colpo.
Al ritorno, le compagne non guardano il pentolino, non vogliono sapere cosa c’è dentro.
“Cos’hai fatto, Armellina, con la veste sporca di sangue?”
E sono la Leda, non più così verde. Tondetta e grossetta, primavere già andate. Ho poca memoria – mi scuso così – e invento terzine pungenti e villane, per darci la forza che serve a mondar.
(Udite? Ho la strofa che sfreccia nel sangue, ché ritmo e cadenza mi danno la lena. Per questo son fatta, non cerco la rima: sollevo la gente piegata al mestier).
Mi piace sentire la frusta schioccare – mi piace rispondere uguale sentir.
Rispetto al padrone io ti manifesto, ma dentro al mio testo morire dovrà. M’ingegno a incitare compagne a cantare: la Rivoluzione, un giorno, sarà.
IO SONO LO SPIRITO DEL TEMPO
e mi han cantato in tanti modi, e il canto che meglio ti parla di me è quello delle tre sorelle.
Per le fotografie di Cremona ©Ferdinando Scianna/AESS-Regione Lombardia Le sorelle Bettinelli, Ripalta Cremasca (CR), 1976
Sondrio: Storia di due pani
IO SONO LO SPIRITO DEL TEMPO
 e vi conto la storia che si contava tra Teglio e Tirano molti anni fa, ché non c’erano luce, automobili, gas. Nemmeno la radio c’era, e la storia si contava così, a parole. Poi, forse, è arrivata fino a Sondrio, e dì lì, per le montagne, fin persino ai laghi, dove ogni tanto senti una ragazzina che ne recita una versione. Ma, anche se alcuni dicono che i nonni dei nonni conobbero i suoi protagonisti, non si sa, questa storia, se sia vera.
e vi conto la storia che si contava tra Teglio e Tirano molti anni fa, ché non c’erano luce, automobili, gas. Nemmeno la radio c’era, e la storia si contava così, a parole. Poi, forse, è arrivata fino a Sondrio, e dì lì, per le montagne, fin persino ai laghi, dove ogni tanto senti una ragazzina che ne recita una versione. Ma, anche se alcuni dicono che i nonni dei nonni conobbero i suoi protagonisti, non si sa, questa storia, se sia vera.
La storia dice così: che a Teglio (ma anche a Tirano) capitava che le donne morissero presto, e lì viveva un Bastiano alto, grosso, nero, calabrese per padre, che faceva il pane nella sua bottega. Quello bianco lo faceva buonissimo, e i sciùr, i ricchi che arrivavano da lontano, lo pagavano a caro prezzo. Ma quel che al Bastiano dava più lavoro, più dannazione e fatica era il pan de seghel perché, essendo calabrese per padre, non gli riusciva buono come voleva: il suo pan de seghel era al massimo come quello di tutti gli altri. Da quando la Stella, sua moglie, era morta, poi, gli sembrava che fosse ancora meno buono.
Il pan de seghel non lo compravano in tanti. La maggior parte se lo faceva da sè, a casa, ché non era difficile: di sera preparavano il lievito, e ci mescolavano acqua e farina. Il mattino dopo gli aggiungevano segale e frumento, acqua calda e sale, a scelta anche uovo e anice. Poi coprivano la madia e facevano lievitare fino a quando non era pronto per farci la ciambella, che è la forma del pane da quelle parti. Alla fine mettevano le ciambelle sulle rastrelliere, e lasciavano lì, anche per settimane, mesi. Ma quelli che facevano il pane in questo modo non l’avevano quasi mai fresco. Così ogni tanto, per non tenersi il desiderio, magari dopo una giornata faticosa, andavano dal Bastiano, al forno, e gli dicevano: “Bastiano, hai mica qualcosa che avanza?”. E Bastiano gli dava una, due ciambelle, spesso senza soldi in cambio, perché tanto lui i soldi li faceva con il pane bianco e i sciùr, e non dimenticava che quando era bambino la gente del posto non l’aveva trattato male perché era mezzo calabrese, e non gli aveva nemmeno fatto il verso quando gli scappava una parola del sud.
 Però, da quando la Stella era morta – ed era ormai passato un lustro abbondante – Bastiano era diventato un altro. Non lo sapeva nessuno, ma lui sì: era diventato cattivo. O almeno cattivo, pieno di rabbia, si sentiva. Ed erano quasi cinque anni che, ogni giorno, messi i piedi giù dal letto nell’alba gelida, qualcosa dentro gli rodeva. Ogni giorno. E ogni giorno, il garzone Hansi – un giovanotto un po’ balengo, ma buono di cuore e anche molto bello – si presentava al lavoro alle sei in punto, dopo una camminata di tredici chilometri. Bastiano gli chiedeva: “Ti dò da mangiare?”. E Hansi rispondeva: “No, grazie, ho mangiato per strada il pan de seghel della Rinella”.
Però, da quando la Stella era morta – ed era ormai passato un lustro abbondante – Bastiano era diventato un altro. Non lo sapeva nessuno, ma lui sì: era diventato cattivo. O almeno cattivo, pieno di rabbia, si sentiva. Ed erano quasi cinque anni che, ogni giorno, messi i piedi giù dal letto nell’alba gelida, qualcosa dentro gli rodeva. Ogni giorno. E ogni giorno, il garzone Hansi – un giovanotto un po’ balengo, ma buono di cuore e anche molto bello – si presentava al lavoro alle sei in punto, dopo una camminata di tredici chilometri. Bastiano gli chiedeva: “Ti dò da mangiare?”. E Hansi rispondeva: “No, grazie, ho mangiato per strada il pan de seghel della Rinella”.
Come Bastiano sfornava a Teglio, la Rinella sfornava a Tirano, in una baitella appena fuori di paese. E una volta che si era fatto portare una ciambella da Hansi, Bastiano si era accorto che il pane di quella ragazzina era molto più buono di tutti i pani che lui avesse mai assaggiato, compresi i suoi. Questo lo faceva impazzire. Anzi, no: la cosa che più lo mandava in bestia era che, dopo averlo studiato con cura, il pane della Rinella, Bastiano era giunto alla conclusione che gli ingredienti con cui era stato preparato erano gli stessi precisi che usava lui. Ma evidentemente una differenza doveva esserci, magari nelle proporzioni con cui venivano miscelate le farine, nel forno, nel tipo di acqua – vai a sapere. Il pan de seghel della Rinella aveva un profumo imbattibile, diverso da quello di tutti gli altri. Un profumo come di violetta. Bastiano aveva provato e riprovato – ma niente. Una volta ci aveva messo dentro dei petali di violette che aveva raccolto in un prato – ma niente. Un’altra volta era perfino andato a Tirano, dove aveva comprato le farine dallo stesso mugnaio da cui si riforniva la Rinella. Aveva riempito un orcio d’acqua di Tirano. Si era fatto dare del lievito locale. Era rientrato al suo forno, aveva impastato e, qualche ora dopo, la delusione: la ciambella era buona – ma niente. Era del tutto identica a quella che faceva tutti i giorni con le sue farine, il suo lievito, la sua acqua.
Dopo un paio di settimane, durante le quali aveva sofferto di una terribile insonnia, Bastiano aveva chiamato Hansi, e gli aveva detto: “Ragazzino, devi fare un lavoro per me. Va’ dalla Rinella e offriti come garzone”. Hansi era rimasto sorpreso.
“Ma… mi volete licenziare? E poi la Rinella non ha bisogno di un garzone, fa tutto da sola!”.
“Non preoccuparti”, gli aveva risposto Bastiano. “Offriti come garzone senza paga: sarò io, in segreto, a pagarti. Dille che vuoi imparare il mestiere”.
“Non accetterà!” aveva risposto Hansi.
“Tu sei giovane e bello. Falla innamorare”, aveva detto Bastiano.
“E poi?”, aveva chiesto Hansi.
“E poi devi guardare come fa il pan de seghel. Guardare bene, capire il segreto. Lo devi scrivere su un foglietto e portarmelo qua!”.
“Ma io non so scrivere!” aveva detto Hansi.
“Allora te lo devi ricordare!” aveva risposto Bastiano.
“Ma io son balengo, non ho memoria!”, aveva detto Hansi.
“Insomma, basta!” aveva tuonato Bastiano. “Va’ dalla Rinella e restaci almeno una settimana, o ti ci porto io a calci!”
E Hansi, a testa bassa, ci era andato.
Che Hansi fosse uno balengo era vero – infatti lui stesso lo diceva. Certo, su una cosa aveva ragione: la Rinella di un garzone non aveva affatto bisogno.
Ma anche Bastiano aveva ragione su una cosa: Hansi era bello, e la Rinella l’avrebbe fatta innamorare sicuro.
C’era un’eventualità, però, che nessuno dei due aveva messo in conto, e cioè che anche Hansi si sarebbe potuto innamorare della Rinella. La quale era una ragazza dolce, gentile, soprattutto molto bella anche lei e che, pur essendo in età da marito, per il troppo lavoro al forno non aveva mai preso in considerazione le profferte dei giovanotti di Tirano.
 Quando Hansi andò da lei a offrirsi come garzone senza paga, andò che la Rinella non gli rispose con la voce della ragione, ma con quella del cuore.
Quando Hansi andò da lei a offrirsi come garzone senza paga, andò che la Rinella non gli rispose con la voce della ragione, ma con quella del cuore.
Non c’era mai stata mattina in cui, dopo avergli venduto la ciambella che Hansi avrebbe mangiato durante la camminata a Teglio – non c’era mai stata mattina in cui la Rinella non lo avesse guardato allontanarsi con un sospiro. “Ma certo che t’insegno a fare il pane!” gli aveva detto.
Non fu quella sera, in cui si erano salutati guardandosi negli occhi senza parlare.
Non fu la sera successiva, in cui Hansi le aveva preso la mano.
Non fu la sera dopo ancora, in cui era stata lei a prendere la mano a lui.
Fu la sera della quarta giornata di lavoro che i due si baciarono, e Hansi finì per fermarsi da lei per la notte.
Quando Hansi si coricò nel letto di Rinella, quella pelle morbida, quei capelli lucenti, e quello straordinario profumo che emanava e che ricordava di aver sentito da qualche parte (ma non avrebbe saputo dire dove), diedero ad Hansi la sensazione di non aver mai vissuto prima di quel momento.
“Bentornato!” disse Bastiano ad Hansi vedendoselo arrivare nell’orizzonte nebbioso dell’alba, una settimana dopo. “Allora, dimmi un po’: qual è il segreto della Rinella? Com’è che lo fa, ‘sto benedetto d’un pane?”.
“Paròn”, disse Hansi, “Io… io non lo so. Lo fa tale e quale a come lo fate voi!”.
“Ma che mi dici, balengo!”, s’infuriò Bastiano.
“N-non c’è segreto! Ci mette il questo e il quello, il quell’altro e l’altro ancora, proprio come voialtro, paròn!”.
“Ma come, galup del boia!”, s’infuriò Bastiano. “Ciurlo d’un balengu! E io che t’ho dato fiducia! Balducc pure mi! Vattene, asinastro, e non farti più vedere, ché non sei utile a nulla!”.
Passò un anno. Ne passarono due, poi tre e quattro. Poi cinque, sei e sette.
Bastiano  s’era ritirato dal commercio. Aveva venduto tanto pan bianco ai sciur del circondario, negli ultimi tempi, che adesso poteva finalmente godersi la vecchiaia nella sua casetta, andare in chiesa a pregare per la Stella e giocare alla morra nel calduccio della taverna di Teglio, dove spesso era quello che tirava in alto le scommesse, perché era quello che aveva più soldi.
s’era ritirato dal commercio. Aveva venduto tanto pan bianco ai sciur del circondario, negli ultimi tempi, che adesso poteva finalmente godersi la vecchiaia nella sua casetta, andare in chiesa a pregare per la Stella e giocare alla morra nel calduccio della taverna di Teglio, dove spesso era quello che tirava in alto le scommesse, perché era quello che aveva più soldi.
Al pan de seghel – bah!, non ci pensava più da tempo.
Un giorno di marzo che era a Tirano per il mercato, al Bastiano venne in mente di passare dalla baitina della Rinella, appena fuori dal paese. “Chissà se quel pane lo fa ancora così buono” pensò, mentre vi s’incamminava con il passo incerto della vecchiaia.
Quando entrò, vide qualcosa, o qualcuno, che gli fermò il fiato in bocca.
“Ha- Hansi?”, disse davanti all’uomo che infornava, la pala in mano.
“Paròn!”, urlò l’uomo, ugualmente sorpreso. “Quanto tempo!”, e andò ad abbracciare il vecchio maestro. “Come state, paròn?”
“Io… io sto bene. Ma… la Rinella?” chiese Bastiano.
Hansi abbassò gli occhi.
Sì.
Era il destino delle donne di quei luoghi. Un destino che il Bastiano stesso conosceva bene. Perciò non gli chiese altro.
Hansi si asciugò gli occhi, e gli allungò una ciambella di pan de seghel.
Bastiano l’addentò.
Era quello. Era quel maledetto, delizioso sapore, lo stesso che lui aveva inseguito per anni, senza successo, dannandosi giorno e notte.
La Rinella non c’era più. E però la magia del suo pane era ancora tutta lì, intatta, miracolosa. E soprattutto: profumatissima.
Ma come poteva essere possibile? Bastiano era sbalordito.
“Hansi, ma… ma lo fai davvero tu questo pane?”
Hansi lo guardò, e sorrise. Il tempo era passato anche per lui.
Lo prese sottobraccio. “Venite, paròn”.
Dietro una porticina all’opposto del forno, Bastiano si scambiò lo sguardo con una ragazzina dagli occhi di una luce impossibile, del sole che cala sul lago a Lovere, alle sette della sera. Le trecce, le gote rubizze. Le mani piccole e fortissime, bianche di farina fino al gomito, che lavoravano l’impasto come se nient’altro di cui occuparsi vi fosse al mondo.
“Vedete, paròn?”, disse Hansi con un sorriso che al Bastiano fece venire le lacrime.
“Lei è Violetta”.
Per le foto di Sondrio ©Laura Losito, Forno di Berola di Cleto della Valle e Anna Petruzio, Ponte in Valtellina (SO), 2014
Premana (Lecco): Per colpa del Borromeo
IO SONO LO SPIRITO DEL TEMPO
 e il Cardinale non m’è mai piaciuto, lui e i suoi emissari della malora.
e il Cardinale non m’è mai piaciuto, lui e i suoi emissari della malora.
Il Cardinale voi che avete studiato, l’avete letto nel Manzoni. Io invece, che sono la Delia dell’alpe, ci ho combattuto. Combattere contro il morto, ve lo dico, è peggio che contro il vivo. E’ più faticoso che spingere la vacca stolida che ha deciso di fermarsi, più rognoso che strappare lo sciargnòn[1] quando hai la schiena di cemento e le mani scarate, più schifido che menar merda al loch[2] quando hai la febbre e il rovescio di stomaco.
Dodici anni avevo, gambette senza pelo, testolina. Oggi mi vedi così, ma immagina te cosa dovevo essere – era prima della guerra. “Va’ all’alpe, fa’ la bes-cera[3]! E stacci!”
E tre mesi stavo, sola, da giugno a settembre, l’intera villeggiatura dei signori di città. A far la bes-cera diventai la Delia dell’alpe, ché a Premana eravamo due, ma l’altra era una moglie e rimaneva giù.
Però non ero solo io, lassù. C’era la vacca Cater, nove pecore e il montone Gabrio. E poi le altre, quelle come me. Anche loro su, da giugno a settembre, ogni qualche domenica giù per la messa quando c’era la comanda dei genitori o era morto un caro. E di nuovo su.
Dice che far la bes-cera era bello. Ci si alzava, si andava rimbambite alla sòsta a munger la vacca, poi giù a portare il latte. Poi baita, colazione – ti lavavi, ti pettinavi. Poi a far legna e dopo mezzogiorno il fieno e di nuovo alla sòsta, dove si aveva la vacca, a portar via il letame.
 Invece giù al paese, due ore di cammino, tutta un’altra vita lontanissima da noialtre. C’erano – ci sono – gli uomini. Che hanno fatto, fanno, sempre faranno una cosa sola: il ferro. A Premana son tutti fabbri. Nel Trecento facevano le spade, le lance. Adesso solo coltelli, forbicine, forbici, forbicioni. Lavorano il ferro – fan solo questo da settecento anni, sono i migliori al mondo e mangiano i nostri formaggi ché carne ce n’è poco niente, forse solo mezza salsiccia a Natale, un’ala di pollo.
Invece giù al paese, due ore di cammino, tutta un’altra vita lontanissima da noialtre. C’erano – ci sono – gli uomini. Che hanno fatto, fanno, sempre faranno una cosa sola: il ferro. A Premana son tutti fabbri. Nel Trecento facevano le spade, le lance. Adesso solo coltelli, forbicine, forbici, forbicioni. Lavorano il ferro – fan solo questo da settecento anni, sono i migliori al mondo e mangiano i nostri formaggi ché carne ce n’è poco niente, forse solo mezza salsiccia a Natale, un’ala di pollo.
Dice che era bello. Ma non era bello per niente. Era una vita dura, sto meglio adesso che sono vecchia arrivata e non c’è un movimento senza un dolore.
E’ stato il Borromeo a decidere come sarebbe andata la mia vita.
Un uomo morto quattrocento anni fa ha detto: la Delia farà così e così, vivrà così e così, e morirà sola, come sola sono oggi.
Il Don – il Gervasoni, il parroco, quello che i miei genitori ingozzavano di galline ogni dì che cadeva in terra – il Gervasoni ha detto: “Io non mi perito, io applico solo la legge del Cardinal Borromeo”.
Quando era vivo, il Borromeo aveva sentito che le ragazze dell’alpe dormivano sole, dentro le baite di famiglia. E aveva anche sentito che c’erano ragazzi che, fattosi tramonto, andavano a trovarle, andavano a fa’ danà[4]. I ragazzi e le ragazze diventarono peccatori, subito, senza prove, senza niente. Il Borromeo mandò allora i suoi sgherri, che si diedero costituzione e stemmi, e costruirono le casine – le casine del Lèc[5], dove le ragazze stavano a dormire non più ciascuna nella loro baita, ma tutte insieme, una sull’altra, sorvegliate da una vecia, una gnech[6], così che nessuno di quelli che venivano a fa’ danà poteva entrare. Oppure poteva, ma poi la gnech andava da mamma e papà e diceva: guarda che tua figlia!
 Trecento e passa anni dopo io ne avevo diciassette, e le cose erano cambiate, perché nel mondo vanno avanti, le cose. E da molto tempo le ragazze dormivano dove volevano, anche nelle grotte, quando andavano a far sciargnòn e non potevano tornare in baita per la notte. Poi è arrivato il Don, e ha detto: basta, torniamo al Borromeo. Coi soldi delle forbici ha rifatto le casine del Lèc, il satanasso, e ci ha risbattute tutte dentro con le gnech. Ma ai ragazzi non gliene importava niente. Venivano, e facevano i dispetti. C’era un fosso, sotto la nostra casina, loro arrivavano vestiti male e sfatti da lavoro. Bellissimi della fatica del giorno, rossi del vino della sera. Portavano gli stracci, ci facevano un fuoco, il fumo entrava in casina, noi dovevamo uscire se no si crepava soffocate. Era bello scappar fuori in camicia da notte, scalze, sentire l’erba fredda sotto i piedi senza vederla. Era bello essere costrette a farci vedere da loro come nessuna di noi avrebbe potuto farsi vedere. Era bello giocare a mari orbe[7], a lotta, a baril[8]. Uno di loro era Errico, il veneziano. Aveva tanti riccioli in testa, rideva sempre e non parlava mai. Le amiche dicevano: quello è un po’ scemo. A me non sembrava, ed era bello e allegro. Ma veniva da Venezia tutti i mesi a cavare il ferro, poi lo riportava in laguna, lo lavorava e lo vendeva. Una volta abbiamo fatto baril, io e lui. E’ stato spericolato. Alla fine, lontano da tutti, al buio, mi ha dato un bacio, e anche di più.
Trecento e passa anni dopo io ne avevo diciassette, e le cose erano cambiate, perché nel mondo vanno avanti, le cose. E da molto tempo le ragazze dormivano dove volevano, anche nelle grotte, quando andavano a far sciargnòn e non potevano tornare in baita per la notte. Poi è arrivato il Don, e ha detto: basta, torniamo al Borromeo. Coi soldi delle forbici ha rifatto le casine del Lèc, il satanasso, e ci ha risbattute tutte dentro con le gnech. Ma ai ragazzi non gliene importava niente. Venivano, e facevano i dispetti. C’era un fosso, sotto la nostra casina, loro arrivavano vestiti male e sfatti da lavoro. Bellissimi della fatica del giorno, rossi del vino della sera. Portavano gli stracci, ci facevano un fuoco, il fumo entrava in casina, noi dovevamo uscire se no si crepava soffocate. Era bello scappar fuori in camicia da notte, scalze, sentire l’erba fredda sotto i piedi senza vederla. Era bello essere costrette a farci vedere da loro come nessuna di noi avrebbe potuto farsi vedere. Era bello giocare a mari orbe[7], a lotta, a baril[8]. Uno di loro era Errico, il veneziano. Aveva tanti riccioli in testa, rideva sempre e non parlava mai. Le amiche dicevano: quello è un po’ scemo. A me non sembrava, ed era bello e allegro. Ma veniva da Venezia tutti i mesi a cavare il ferro, poi lo riportava in laguna, lo lavorava e lo vendeva. Una volta abbiamo fatto baril, io e lui. E’ stato spericolato. Alla fine, lontano da tutti, al buio, mi ha dato un bacio, e anche di più.
Qualcuno deve averci visto, e la mattina dopo è venuto su il Don. A me non importava niente, io l’Errico l’avevo sognato tutta la notte.
“Confessati”, mi ha detto il Don.
“Io non ti confesso proprio niente”.
L’Errico non l’ho visto mai più.
Le amiche e una gnech mi hanno detto che dopo quella notte l’hanno accusato di rubare il ferro, e il Don l’ha fatto carcerare a Venezia. Poi, dicono, è partito per la guerra, e non è più tornato.
Io non ho mai più giocato a baril con nessun altro, perché mai, dopo, in tutta questa vita, ho incontrato qualcuno che non volesse niente in cambio di un sorriso, anche se era il sorriso – forse – di uno un po’ scemo. Così, ancora oggi, mi capita di sognarlo ancora, la notte.
Se la Delia si doveva sposare con qualcuno, era con lui.
Ma per colpa del Borromeo, niente.
Per le foto di Premana ©Pierluigi Navoni/AESS-Regione Lombardia Premana, 1992
[1]Tipo di fieno che nasce nei dirupi, faticoso da raccogliere.
[2] Appezzamento di terra, o anche prato di proprietà coltivato a maggese.
[3] Fare bes-cera, ovvero la vita dell’alpe: portare la mucca, condurre il gregge, gestire il letame, far fieno.
[4] “Far dannare”, “Far danni”
[5] “Casine del letto” o “dei letti”.
[6] Zitelle che fungevano da sorveglianti, in grado di riferire ai genitori delle ragazze eventuali comportamenti sconvenienti.
[7] Una sorta di mosca cieca: il ragazzo si bendava gli occhi e, toccando le ragazze, doveva indovinarne l’identità. Se lo faceva, riceveva un bacio dalla ragazza in questione.
[8] Altro gioco finalizzato a favorire il contatto fisico: un ragazzo e una ragazza avvinghiati dovevano riuscire a rotolare sul pavimento o sulla paglia senza mollare la presa, ed evitando di aiutarsi con gli arti.
www.aess.regionelombardia.it


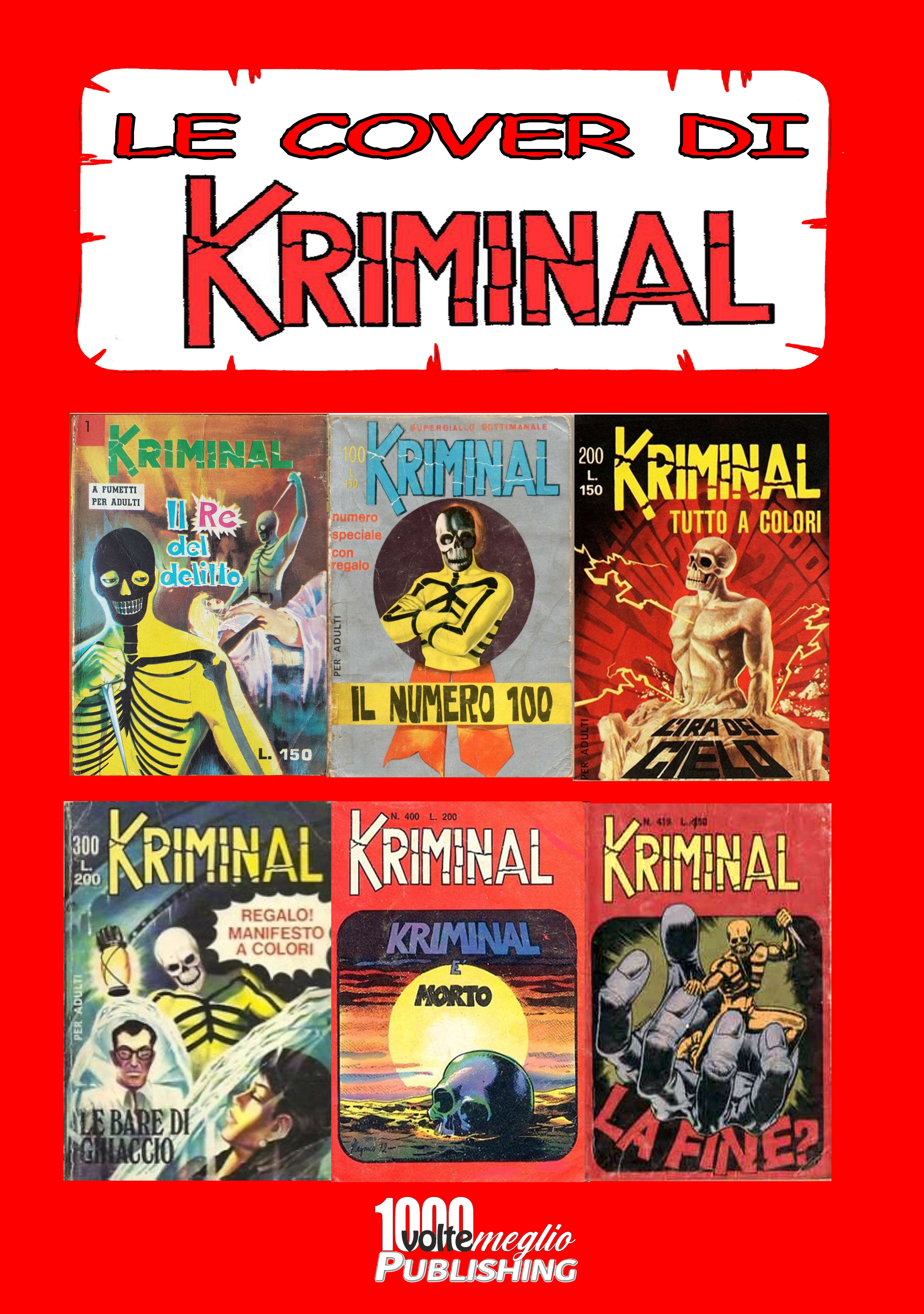

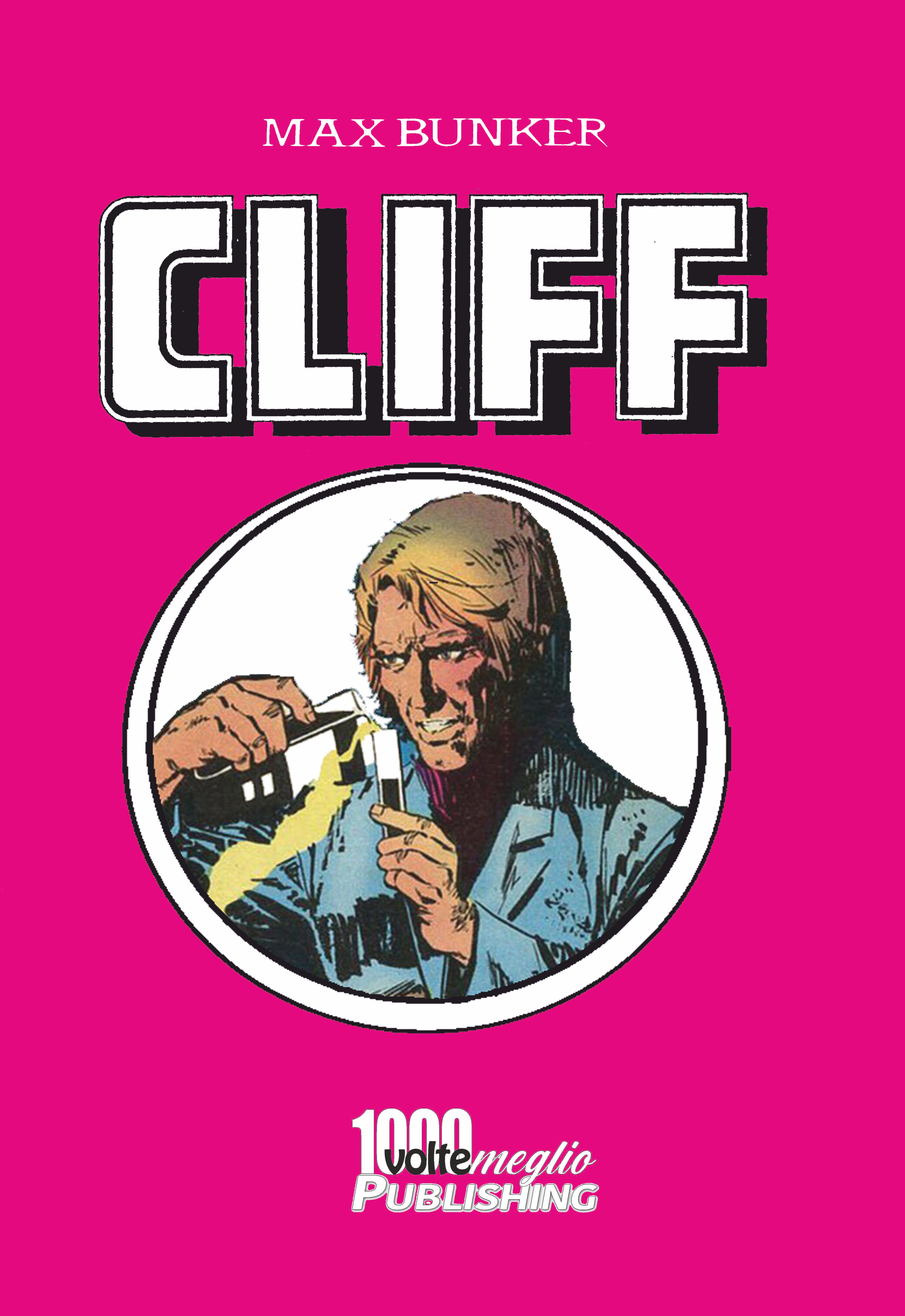
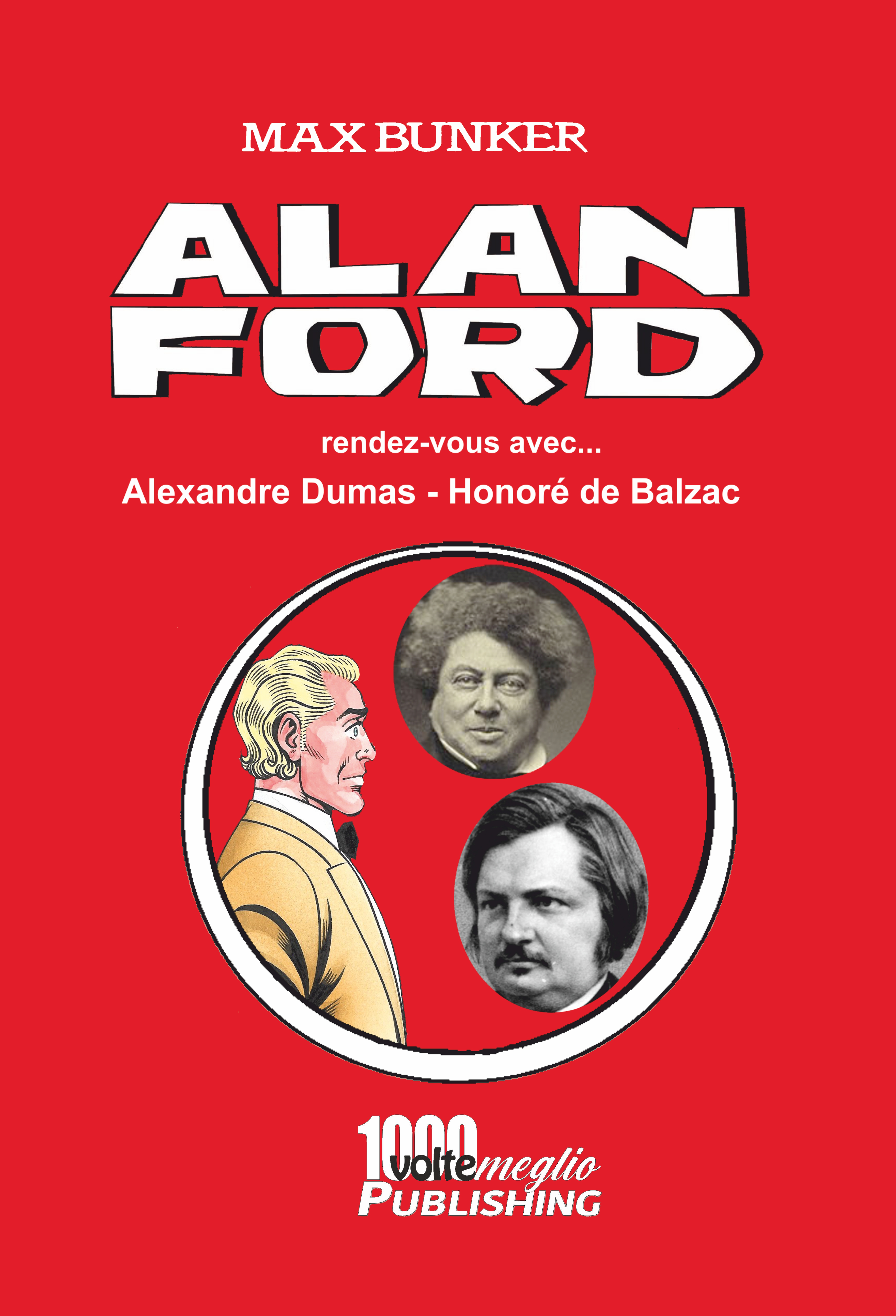

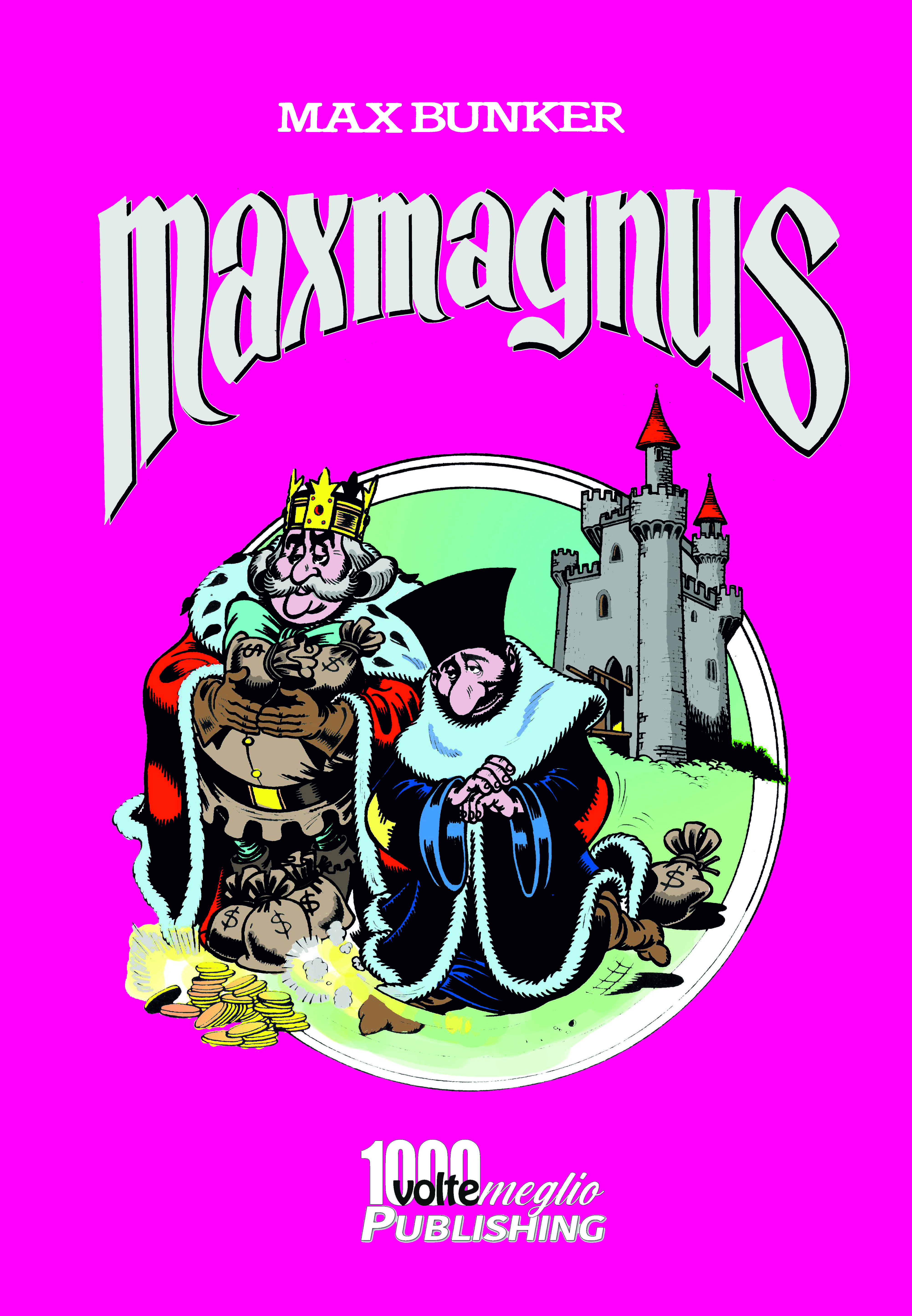











Lascia un commento